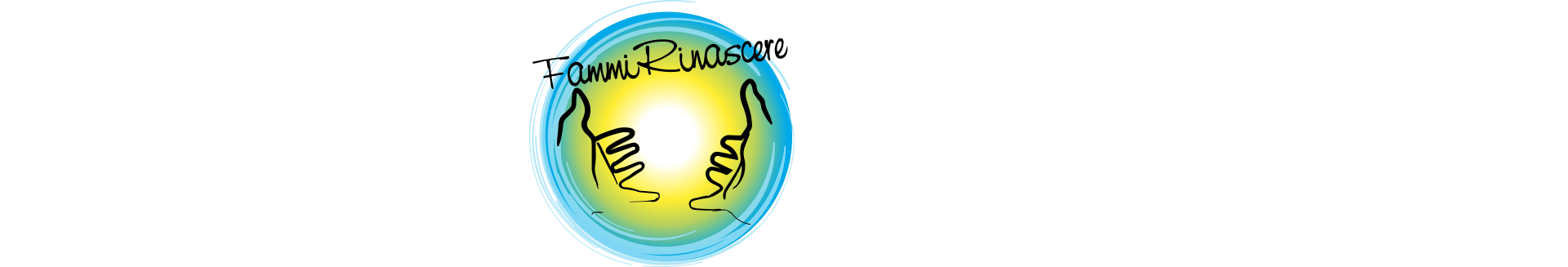Osservatorio sulla violenza contro le donne n. 3/2022 - Il caso A.F. contro Italia davanti al Comitato CEDAW
I pregiudizi giudiziari contro le donne all’esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia

Con la pronuncia A.F. contro Italia (148/2019) del 20 giugno 2022 (in allegato la traduzione non ufficiale) il Comitato CEDAW ha ritenuto che lo Stato italiano abbia violato gli artt. 2, 3, 5 e 15 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)[1] nel caso di una donna che il giorno successivo all’aggressione dell’ex marito aveva denunciato di essere stata stuprata proprio dall’agente della polizia giudiziaria, C.C., incaricato delle indagini, che si era presentato nel suo appartamento adducendo falsamente di avere informazioni sul suo caso. È la prima volta che il Comitato CEDAW[2] (da ora in poi Comitato) si pronuncia su un caso italiano, tanto da rendere questa decisione di particolare rilievo perché promana da un organismo dell’ONU.
PERCORSO GIUDIZIARIO
Il Tribunale di Cagliari aveva condannato C.C. a sei anni di reclusione per violenza sessuale, dichiarando la prescrizione per il reato di molestie telefoniche, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, A.F., per come ulteriormente comprovate dai testimoni che da questa avevano appreso delle violenze subite (avvocato, psicologo, medico del Pronto soccorso, altro Carabiniere, amiche) e da altre donne, con cui l’uomo aveva intrattenuto relazioni tutte cessate per le sue condotte persecutorie e violente (una delle quali contattata sempre nel corso di indagini di Polizia giudiziaria); sull’analisi del DNA dello sperma; sui tabulati telefonici; sulla certificazione medica della ginecologa, ritenendo illogica la versione dell’imputato.
La Corte di appello di Cagliari aveva assolto C.C. per insussistenza del fatto per le incongruenze rinvenute nelle divere dichiarazioni rese da A.F., con specifico riguardo alla ritenuta illogicità dei comportamenti assunti dalla donna prima e dopo il denunciato stupro, con particolare riferimento (§ 2.15 della decisione del Comitato): a) al non avere segnalato al medico fiscale la presenza in casa del Carabiniere che poi l’avrebbe violentata; b) al mancato riferimento all’uso del preservativo; c) all’avere messo da parte le lenzuola in cui era avvenuto il delitto, al fine di comprovarlo; d) all’avere fatto da palo mentre C.C. usciva verificando che non ci fosse nessuno; e) all’avere telefonato a due amiche dopo lo stupro. Sulla base di questi elementi i giudici avevano ritenuto che la donna avesse «ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere, rendendosi poi conto di essere stata semplicemente usata per un’avventura momentanea, e per essere stata, subito dopo, abbandonata dall’altro uomo di cui si era nel frattempo innamorata» e che si fosse recata in ospedale per proteggere la sua reputazione e così «vendicarsi dell’imputato». I certificati medici che rivelavano i lividi sulle ginocchia e le perdite ematiche erano stati interpretati come una prova «dell’esuberanza» di C.C. e della sua «capacità di seduzione».
La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso della parte civile ritenendo - dati i limiti del giudizio di legittimità, volto ad accertare solo la tenuta del discorso giustificativo del provvedimento impugnato - congrua e logica la motivazione della Corte di appello sia sull’uso del preservativo come prova della «consensualità del rapporto sessuale», sia sull’inattendibilità della testimonianza della persona offesa.
LA DECISIONE DEL COMITATO CEDAW
La ricorrente, tramite avvocate specializzate in diritti umani delle donne, ha denunciato al Comitato l’utilizzo di stereotipi sessisti, puntualmente elencati, da parte della Corte d’appello, tali da impedirle la tutela dei propri diritti fondamentali, non censurati dalla Corte di Cassazione che, infatti, non ne aveva rilevato il contrasto con la CEDAW e con le sue Raccomandazioni (§§ 3.1. ss. e §§ 5.1 ss.)[3].
Lo Stato italiano, nell’escludere la fondatezza del ricorso, dopo avere precisato che l’obbligo della rinnovazione delle prove orali in appello nel nostro sistema vale solo se si ribalta una sentenza di assoluzione (§§ 7.4 ss.), ha richiamato i progressi del nostro Paese in materia di violenza contro le donne, sotto il profilo legislativo e formativo, e il pieno rispetto della Convenzione di Istanbul[4] e della CEDAW del nostro sistema penale (§§ 4.5 ss.).
Il Comitato, verificato che la ricorrente aveva esaurito tutte le vie di ricorso interno, ha spiegato che la disuguaglianza cui sono esposte le donne non è basata solo su leggi e procedure, ma risiede «anche nella mancanza di capacità e consapevolezza delle istituzioni giudiziarie e paragiudiziarie di affrontare adeguatamente le violazioni dei diritti umani delle donne» e che «stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne (…) distorcono le percezioni e portano decisioni basate su credenze di preconcetti piuttosto che su fatti rilevanti (…) Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni. Questi stereotipi possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi» (§ 7.5). Con specifico riferimento all’ambito del diritto penale, gli stereotipi fanno sì che «i colpevoli non vengano ritenuti legalmente responsabili per le violazioni dei diritti delle donne, sostenendo così una cultura dell’impunità. In tutti i settori del diritto, gli stereotipi compromettono l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario e possono, a loro volta, portare a errori giudiziari compresi la rivittimizzazione dei denuncianti» (§ 7.5).
Nel caso specifico, il Comitato ha rilevato come la Corte di appello abbia ribaltato la decisione del Tribunale formulando ipotesi ed esaminando prove alla ricerca «di giustificazioni alternative» e abbia fondato la propria decisione «solo su stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al racconto dell’imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa» (§ 7.16):
la prova del preservativo ha portato ad escludere l’assenza di consenso «poiché se C.C. si fosse soffermato a mettere il preservativo, ci sarebbe stato un momento in cui una vera vittima di stupro sarebbe certamente fuggita» (§ 7.9);
i lividi sulla parte interna delle ginocchia della donna, in assenza di una spiegazione dettagliata dell’esatta natura della forza usata per tenerla giù, «potevano essere spiegati dall’esuberanza di un incontro consensuale. [La Corte] ha respinto tutte le prove peritali dell’ospedale, del ginecologo, dello psicologo, dell’avvocato e di altri testimoni come non attendibili, in quanto si basavano sulla versione dei fatti fornita dall’autrice [A.F.] dopo aver preso la decisione di incriminare C.C. e di farlo cinicamente entro i termini di legge» (§ 7.9);
[la Corte] ha concluso che «le scelte e i comportamenti lucidi dell’autrice non erano indicativi di una persona che era stata violentata (…) ha ritenuto sospetto il fatto che l’autrice avesse raccolto prove fisiche dopo l’aggressione e avesse cercato di prendere l’imputato in trappola. La Corte ha sostenuto che una donna single e non molto giovane sarebbe intrinsecamente preoccupata della sua reputazione che potrebbe essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, di cui dovrebbe essere lusingata e che è prevedibile che una donna di questo tipo diventi vendicativa in caso di rifiuto (…) La Corte ha anche affermato che una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi o per ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari e ha ritenuto che questa fosse la narrazione più probabile rispetto ad affermazioni dell’autore» (§ 7.11);
dal canto suo, «la Corte di cassazione ha ritenuto che tali argomentazioni fossero logiche» (§ 7.13);
il trattamento riservato alla donna, prima dalla Corte di appello e poi «aggravato a livello di Corte di cassazione, non è riuscito a garantire l’uguaglianza di fatto dell’autrice in quanto vittima di violenza di genere e nasconde una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, dell’implicazione delle complessità dell’abuso di autorità, compreso l’uso e l’abuso di fiducia, dell’impatto dell’esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici» (§ 7.17).
Leggi di più su
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/osservatorio-violenza-contro-le-donne-2022-3-caso-af-contro-italia-comitato-cedaw
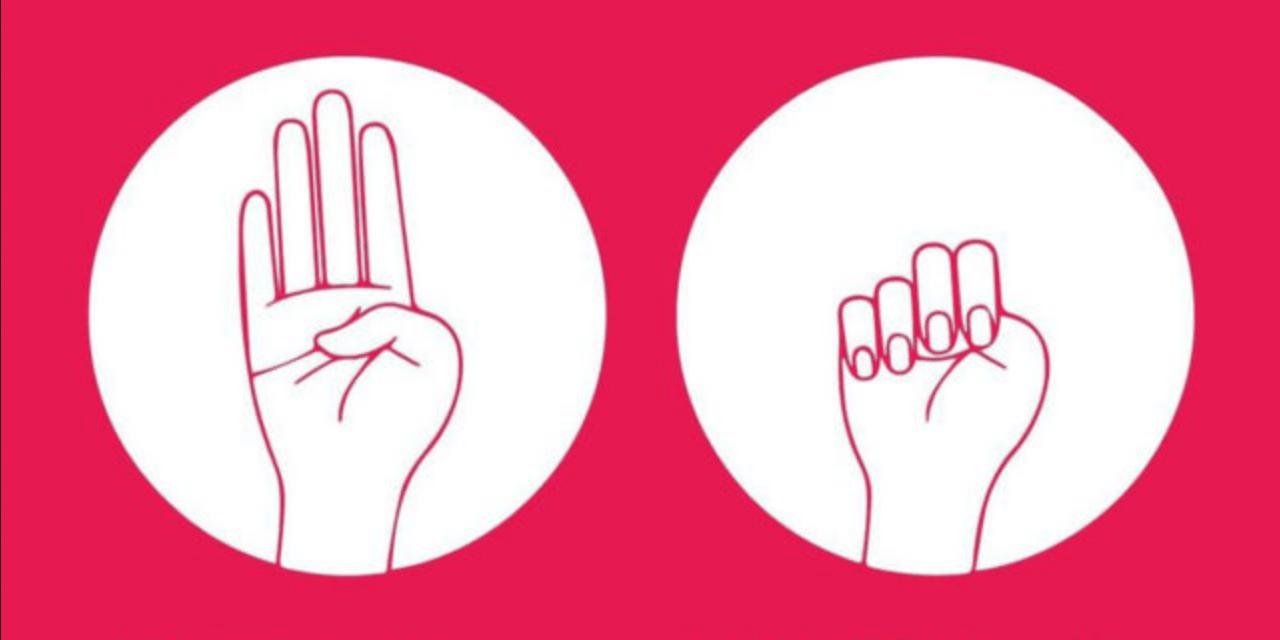

Tutti i diritti riservati | APS CALCUTTA
C.F. 92024570605 | Informazioni legali | Informativa sulla Privacy | Privacy Policy e Cookie Policy
Powered and designed by Creativi Su Misura